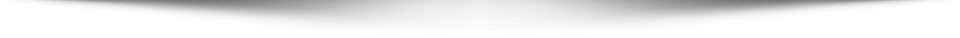- Parlaci del tuo ultimo romanzo, “Le crepe del Paradiso”. Quando e in quali circostanze ti è venuta in mente l’idea di concepire questo scritto?
La mia opera letteraria è legata a particolari tematiche esistenziali: vita, tempo, essere, fine e senso. Dopo circa una decina d´anni, il romanzo appena uscito (di 340 pagine) è scaturito da un’opera complessiva, di cui sarebbe (stato) l’ultima parte. Il sottotitolo “Eclissi di un’infanzia” allude alla prima apparizione delle grandi domande e dubbi dell’infanzia, in primis quelli sulla morte, vista attraverso gli occhi di un bambino-chierichetto, in un contesto cattolico. Questa cultura vorrebbe persuaderlo all’ideale dell´ immortalità individuale: quando siamo generati, non possiamo più sparire. Il protagonista Alessio, bambino tra gli 8 e i 12 anni (descritto nel suo percorso cronologico di crescita), è un chierichetto particolarmente amato dal parroco; il destino gli assegna il compito di accompagnare il sacerdote a ripetute celebrazioni di funerali, con relative sepolture e una fiumana di emozioni traumatizzanti. Questo lo porta a contatto fisico con la morte del prossimo, nel momento stesso in cui il sacerdote educatore e l’intera comunità ecclesiale e familiare provano a convincerlo che la morte non esiste: la sua rappresentazione attraverso i suoi occhi destabilizza la sua edenica visione precedente. “Le Crepe del paradiso” sono la prima forma di “crepe”, nella rappresentazione dell’eternità da parte di un bambino, che comprende che l’eterno può avere i tratti di una menzogna, di un colossale inganno: la fine dell’uomo intacca l’inizio, la permanenza dell’eterno. Tutto ciò fa tremare come in un terremoto le certezze e il vecchio paradiso costruito attorno al protagonista.
Il messaggio del libro è il seguente: il tempo dell’uomo è infinito ma, quando l’esperienza mostra il contrario, ci si pone innanzi all’impatto che la morte suscita all’interno della rappresentazione radicale di un bambino. “Eclissi di un’infanzia”: l’infanzia comincia a finire, quando le risposte iniziano a prevalere sulle domande, non soddisfacendole.
- Alla luce della tua duplice formazione di letterato e filosofo, in che modo il tuo percorso di studi è riscontrabile nella tua vita di romanziere, influenzando la narrazione di questo romanzo?
L’immaginazione e la fantasia prevalgono: tematiche che hanno a che fare con il tempo e il senso. Per un filosofo, è pericoloso provare a esprimere i propri concetti in letteratura, che è la “zona delle emozioni”, ma non dei ragionamenti, ad eccezione del genio Musil, ne “L’uomo senza qualità”. I grandi narratori del Novecento non hanno mai “saccheggiato” la filosofia all’interno della letteratura. Chi mi conosce, sa che ho scritto di filosofia, pur non essendo un vero e puro filosofo. Ne “Le crepe del Paradiso”, la problematica non è narrata in modo filosofico, pur essendo intrisa di grandi tematiche filosofiche. Ciò che prevale è l’immagine: di filosofico, vi sono le problematiche che ho sempre affrontato come lettore di Heidegger, Nietzsche e Sartre, ma rimane pura narrazione.
- Come avviene l’evoluzione -in termini di maturità- da parte dell’adolescente protagonista?
È un romanzo di “aborto della formazione” in attesa del “ripristino di una formazione”. La deformazione è diretta verso lo stravolgimento, il riadattamento. Il bambino non accetta la formazione e la vocazione che gli vengono imposte. Nel primo capitolo del romanzo, viene narrato un tentativo di convocazione alla scelta clericale -da parte di un prete- nei confronti di un piccolo chierichetto: il sacerdote prova a trasformare il bambino in un altro sacerdote. Si tende a inserire il bambino in una gabbia. Spesso, noi siamo “pensati dal pensiero degli altri”. Oppure, chiamati dalla chiamata degli altri, spacciata come chiamata di Dio. Durante l’infanzia, veniamo messi in “bolle” che rimangono tali, finché non vengono smascherate. All’interno di quegli anni, dopo aver visto le “smagliature” della propria esistenza, il bambino assiste alla morte di nonni, parenti, sconosciuti, compagni di scuola: scoperte di una mortalità che incrocia gli affetti e sconvolge la sua giovane sensibilità…In seguito, vi sono altre esperienze di “crepe”, situazioni di lutto, tra cui i funerali di un suicida.
In tal senso, vi è una crescente presa di coscienza del fatto che la realtà non è quella che viene rappresentata. Non si tratta una vera e propria “evoluzione” in termini narrativi, ma di uno sviluppo ellittico, fatto di piccole catastrofi e grandi trasformazioni.
- Nell’economia della tua produzione letteraria, qual è il significato di questo libro?
Si inserisce in una “tematica centrale” della mia filosofia. Ho sempre posto il tempo, come forma della rappresentazione della vita, in chiave tragica o metafisica. In questi ultimi anni, è emerso invece il tema dello spazio come salvezza e varco, per raggiungere una dimensione di stabilità, come l’eternità (che ha a che fare con la salvezza). I protagonisti delle mie opere hanno ritrovato la salvezza attraverso il varco spaziale (anziché il tunnel temporale). Esattamente come la “via di fuga”, che sfugge allo stritolamento del tempo, attraverso lo sguardo e i sensi. Si tratta di una delle tematiche che caratterizzano la mia opera, da 10 anni a questa parte, a livello estetico e ontologico. La contemplazione dello spazio mi dà l’idea di una possibilità di fuga, come libertà. Accade già alzando lo sguardo verso il cielo, osservando lo spazio interstellare, tema precedente nella “Cella della dea” e in “Preludi e deliri”. Il “varco” è al di là del limite della morte, che è impossibile assoluto. L’impossibilità che sperimenta il bambino del mio romanzo è ciò contro cui il bambino cerca tale varco, al di là del destino della morte sfuggito alla rappresentazione religiosa e irenica dei limiti umani. Le crepe del Paradiso sono le prime smagliature della verità e della gioia: nella casa dell’anima, Alessio proverà a trasformare quei limiti, in occasioni di futuro, di rigenerazione, quelle crepe in varchi oltre la casa pericolante.
ALCUNI “PASSI” FONDAMENTALI DEL LIBRO:
IL PRINCIPIO DELLA FINE
Tutto cominciò, e cominciò a finire, quando non mi rimase nulla di quello con cui ero partito, il bagaglio che mi aveva accompagnato nel viaggio, gli effetti personali divenuti da im- memorabile tempo le appendici, le vecchie pelli o le inutili zavorre di ciò che ero. Tutto cominciò, insomma, e cominciò a volgere alla fine, quando sui palmi aperti delle mani, all’alba, non avvertii più nemmeno la sensazione dolce, prensile, pru- riginosa, di ciò che si era materializzato nel corso della not- te, nel magico pozzo dei sogni, e che ora evaporava. Monete, gioielli, tesori ritrovati nelle sabbie di oasi esotiche, o sottratti a grandi magazzini di metropoli, soffiati alle banche o agli uf- fici postali. Ma anche mani protese di amici, conosciuti per caso lungo le affollate strade del mondo, e seni di fanciulle e di giovani donne, o labbra dall’umore tiepido che ancora bagnava le mie dita. Non c’era più niente da stringere, i miei palmi rimanevano aperti e vuoti, le dita appena un po’ incur- vate, pronte a chiudersi su quanto le alte maree dei sogni si compiacevano di depositare tra le mie mani spalancate, simili a foglie carnivore in attesa del solo contatto di uno scarabeo o della più leggiadra delle libellule per accartocciarsi sulla preda e stritolarla.
Mi risvegliavo senza stringere niente, senza rimpiangere niente, nudo come millenni prima, come nell’attimo remoto in cui mi ero addormentato. Accanto a me nemmeno il fantasma
11
di un oggetto da possedere, mio. Uno stato di definitiva pover- tà, più velato di stupore che di angoscia. Il ritorno a un’asso- luta selvaggia nudità priva di vergogna. Non avevo niente, non possedevo niente. Neppure nei sogni avevo costruito qualcosa, nemmeno navigando nel teatro della mia mente addormentata mi ero guadagnato un bottino, una preda, o una mano da strin- gere. Se qualcosa era avvenuto, se qualcosa avevo ottenuto, tutto era scivolato via, anche il desiderio di averlo, di portarlo con me al risveglio: anche la nostalgia. Le mani non avevano memoria neanche di una pietra o di un filo d’erba da stringe- re, e le dita rimanevano aperte, divaricate, come di chi lasci scorrere pugni di sabbia finissima, dispersa dal vento insieme all’antica speranza di granelli d’oro. Questo mi sembrava ora- mai di essere un setaccio incapace di separare i granelli d’oro dalla sabbia delle dune, essendo bucherellato da tutte le parti, come un colabrodo, o uno scudo di guerra mitragliato.
Ma se l’incontinenza era diventata il mio modo d’essere, e non rimaneva nulla, giorno dopo giorno, di quanto avevo vi- sto, toccato, dei tesori conquistati, rubati, ritrovati, delle mani strette per le strade del mondo, e delle labbra di donna che avevano tremato sotto le mie come nell’incanto dei sogni, – se non rimaneva per di più la memoria di tutto questo dentro la calotta di un cranio che ogni cosa bruciava come forno nel tempo, cremava e inceneriva e lasciava ogni residuo al vento con una selvaggia velocità, – era ovvio che non potevo più contare su ciò che avevo, così come non potevo più contare in genere, né numeri, né giorni, né proventi, risultati, guadagni: inventari di oggetti e opere compiute, acquisti e progetti, doni, gratificazioni e manne dal cielo. Anche se avessi continuato ad avere, ad ottenere, a riporre il passato e l’intera vita nei gra- nai del profitto o del riconoscimento, le botole sotto i miei piedi avrebbero continuato ad aprirsi come le dita delle mie mani e a lasciar colare tutto dentro pozzi senza fondo, buchi neri e gole abissali incapaci di restituire alcunché, nemmeno la memoria di quanto avessi ricevuto, nemmeno la nostalgia di quello che mi era sfilato davanti e si era perso. Avere, me lo dicevano quei palmi vuoti, non era più la mia strada. Avevo le mie mani, aperte sulle lenzuola all’alba, sempre pronte a rice- vere, a custodire, ma da tempo disilluse: spalancate solo per- ché il vuoto su cui si sarebbero richiuse, contraendo le dita, sarebbe stato un altro, diverso vuoto di vento che ora in qual- che impalpabile modo le carezzava, senza indurle ad accar- tocciarsi sulla vita come foglie carnivore. Ma neanche le mie mani mi appartenevano, nè facevano parte della contabilità. Non le avevo. Quelle mani dicevano io e non potevo disporne, come non potevo disporre di chi le osservava. Rimanevo con loro e con me, ma né loro né me mi appartenevano. Poteva appartenermi soltanto ciò che avevo, ma ciò che avevo si pol- verizzava all’alba, e il fantasma di quella polvere aleggiava su ogni ora della mia giornata. Ecco perché riaprendo gli occhi, a ciascun risveglio della notte e del giorno, non mi chiedevo più da tanto ormai cosa avessi di mio, e che cosa i sogni della notte o i fantasmi del giorno mi avessero portato per arricchire ciò che ero. Mi chiedevo semplicemente chi ero. Lo reclamavano i palmi ancora aperti sulle lenzuola, come a ricevere qualcosa. Ma essi stessi ormai non chiedevano, ma domandavano. Era- no come me, erano e basta, e non attendevano più monete, gioielli, mani o labbra di donne: aspettavano di sapere, inter- rogavano ciò che le carezzava impalpabilmente, come brezza di aprile: il vuoto. Su quel vuoto non si chiudevano mai. E anche se si fossero richiuse il vuoto sarebbe filtrato via come nuova sabbia di deserto dalle dita serrate. Non c’era nulla da prendere, c’era più da capire.
Eppure anche il capire era un prendere. C’era più da sa- pere. Ma nemmeno. Guardavo le mani che aprivano i palmi al soffitto della camera da letto, ove pendeva il lampadario spento. Sembravano occhi spalancati che non volevano cat- turare, non volevano comprendere, capire, sapere. Cercavano semplicemente di vedere. E non c’era bisogno di accendere il lampadario o spalancare le imposte alla luce irrompente del giorno. Si trattava di lasciare che tornasse a me, alle mie mani ed ai miei occhi come palmi aperti, l’immagine del bagaglio
12
13
con cui ero partito, anni fa o millenni, per questo viaggio come probabilmente per cento altri, nei pozzi della notte e nel bagliore dei giorni, nella marea dei sogni o nell’intricata boscaglia di quella che mi pareva la realtà. Quel bagaglio ero io, una valigia vuota che si interrogava alla fine di ogni tappa del viaggio, di ogni fermata di stazione, e si chiedeva chi l’a- vesse condotta lì, e come, e per quali strade.
Tutto cominciò, e cominciò a finire, quando – esaurite le scorte dell’avere e del custodire – non mi restò che vedere, con quello che mi rimaneva degli occhi, delle mani, e dell’antico primitivo bagaglio.
c) Il colloquio
La zia Xenia si allontanò coi suoi passi felpati e richiuse piano la porta. Don Luciano spazzò rapidamente col palmo della mano le ultime briciole, e mi invitò ad accostarmi un po’ di più con la sedia. Mi ritrovai a sfiorare con le mie ginoc- chia la gamba di gesso e a pochissimi centimetri dai suoi oc- chi umidi che ora mi fissavano con una intensità nuova. Ebbi l’impressione che con i suoi santi occhi di felino mi fissasse come una preda. Sulle sue labbra carnose e sorridenti era at- taccata ancora una briciola di Alemagna. A me non rimase che chinare il capo e ascoltare la sua voce profonda e nasale che mormorava: «Lo sai che Dio Padre sceglie i suoi servitori…». Annuii col capo. «Come Gesù scelse i suoi dodici apostoli». Annuii ancora, più lungamente. «Gesù e tuo amico e ti vuole bene. Gesù ti osserva. Anche se non te ne accorgi, in questo momento il tuo amico ti osser- va…». Gesù mi osservava, ma effettivamente non potevo vederlo avendo le palpebre chiuse. Tuttavia era nel buio dell’anima, mi rassicurava don Luciano, che dovevo vedere Cristo Reden- tore, il quale sfoggiava probabilmente i suoi occhi intensi di gatto, per giunta fluorescenti. «In fondo a questa sala, in una piega della parete accanto allo scrittoio, vi è un crocifisso in legno d’ulivo. È sempre in ombra, ma da quell’ombra Gesù ora ti vede. Lui vede anche al buio». Come le linci, pensai. «Ti senti osservato da Gesù?».«Certo», risposi. «Ti senti amato da Gesù?». «Certo», ripetei. Sollevai lo sguardo verso la piega della parete ed effettivamente, tra due vasi con rametti di ulivo, ci sovrastava un crocefisso scuro, quasi mimetizzato nel vano ombroso. E mi parve quasi di bestemmiare col pensiero, come spesso mi accadeva, considerando che il capo di Gesù trafitto dalle spine e crollato verso il basso, come decollato, mai e poi mai avrebbe potuto alzare e indirizzare il suo santo sguardo di moribondo straziato su di me. Ci fu una pausa. Una pendola oscillava da qualche parte. Il fruscio che proveniva da fuori era quello degli pneumatici delle macchine e dei tranvai sulla neve. «E ti senti scelto da Gesù?», domandò don Luciano sof- fiandomi il suo alito fresco di Pasta del Capitano sul viso, con una voce acuta, metallica, che gli usciva di solito dalla gola suo malgrado quando temeva la risposta. Scelto era una parola che non comprendevo bene. Se don Luciano avesse precisato subito per cosa, scelto per cosa, avrei capito. Così intuivo solo che per qualche motivo, con la com- plicità o la mediazione di don Luciano – un ambasciatore del Santissimo, secondo mia madre –, Gesù in persona mi aveva messo gli occhi addosso. «Allora? Non te la senti di rispondere? … È comprensi- bile. La chiamata esige tempi lunghi di risposta. Come per Abramo, per Ismaele, per San Paolo. Chi risponde troppo in fretta lo fa per paura o per inerzia, non per vocazione. Voca- zione… – don Luciano pronunciò questa parola lentamente, sillabando, come se la bocca gli brillasse di argento fuso –, sai cosa vuol dire?».
38
39
«Forse. No. Non esattamente». «Tu pensi a Gesù?».«Sì».«E ci pensi poco o molto?». «Molto». «E sai perché ci pensi?». «Non lo so». «Se Gesù non ci fosse credi che potresti pensare a lui?». «No, non credo». «Dunque Gesù esiste». «Sì». «E se Gesù non pensasse molto a te, credi che tu potresti pensare molto a lui?». «Sì… No. Cioè… non lo so». «Te lo dico io: no. Giusto?».“No… Cioè, sì». «Gesù è dentro i tuoi pensieri. È lui che ci entra, che pren-de posto, non i tuoi pensieri che lo inventano. Ti ha chiamato. Tu ne senti la presenza e la voce. La sua parola ti abita. Quella croce accanto allo scrittoio è dentro di te. Il tuo più grande amico ti chiede di portarla. È questa la vocazione».
Stefano Chiesa