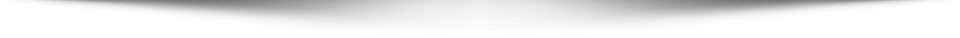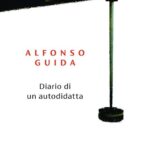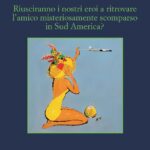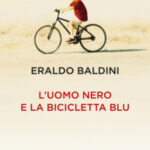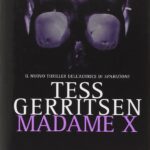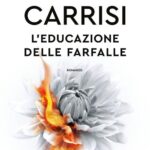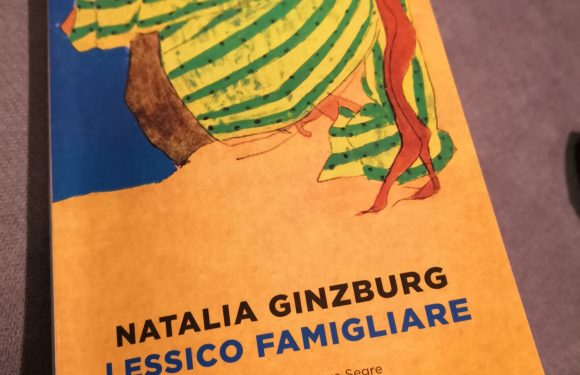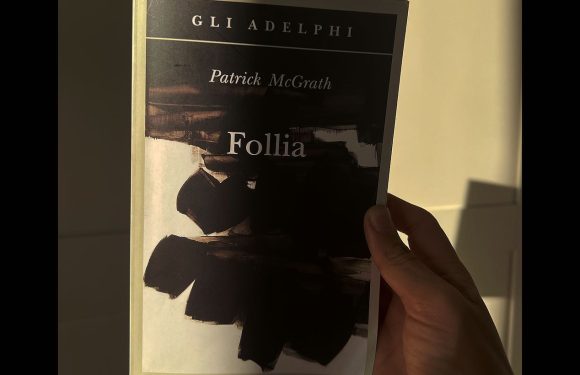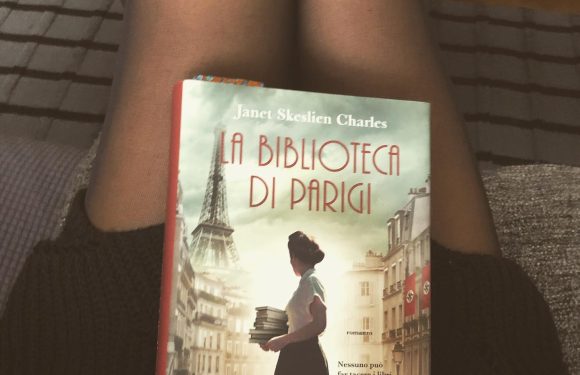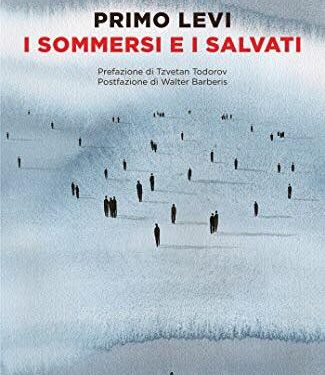
LA SHOAH E I BIAS
Novembre 22, 2022Qualche giorno fa ho visto il bel film “LA VERITÀ NEGATA”, che racconta la storia del processo contro Deborah Lipstadt a fine anni ‘90 intentato da John Irving, scrittore che nega la Shoah.
Il film è molto bello. Narra di quanto la studiosa americana fosse impulsiva e non riuscisse a capire la strategia vincente degli avvocati che la difendevano.
Il punto cruciale sta nel fatto che la Lipstadt nel suo libro sul negazionismo aveva sostenuto che Irving avrebbe falsificato i dati per dimostrare le sue tesi negazioniste.
In effetti, nel film, il giudice, verso la fine esprime in tribunale il suo dubbio. Di sicuro gli avvocati hanno dimostrato che le tesi negazioniste di Irving sono basate su dati falsi, ma come facciamo a essere sicuri che Irving non abbia sbagliato in buona fede guidato dai suoi bias?
Bisognerebbe leggere le 300 pagine della sentenza, oppure l’omonimo libro scritto dalla Lipstadt che racconta il processo per sapere che cosa abbia convinto il giudice del dolo di Irving.
In effetti una cosa è il negazionismo, cioè sostenere una tesi evidentemente falsa, che però è considerata reato in molti paesi. Una cosa è falsificare i dati artatamente. Questo non è un reato, però se in un libro si afferma che lo si è fatto e non è vero, si rischia la querela per diffamazione, come è successo alla Lipstadt.
Infine non mi sembra sensato parlare di negazionismo quando senza negare i fatti si propongono strane interpretazioni della Shoah. Ne elenco alcune che trovo poco convincenti.
1. La sacralizzazione. La Shoah sarebbe un olocausto, cioè una sorta di sacrificio divino. Il Dio giudaico Cristiano non vuole sacrifici fin da quando ferma la mano di Abramo che sta per uccidere Isacco.
2. È un genocidio come tanti altri motivato da ragioni pratiche. No purtroppo, dietro alla Shoah c’è un furore ideologico.
3. È una espressione della civiltà della tecnica. La tecnica gioca un ruolo decisamente secondario nella Shoah. Quello che invece si vede è la forte capacità deresponsabilizzante della divisione del lavoro.
4. È la fine della morale. La morale è un tentativo umano di comprendere quali sono i comportamenti migliori e non vedo come un qualsiasi comportamento umano, compresa la Shoah, possa impedire questa ricerca.
5. È la fine della teologia. Come sarebbe possibile Dio dopo Auschwitz? È senz’altro la fine di una teologia antropocentrica. Ma questa teologia era già stata confutata dagli scrittori del libro di Giobbe, elaborato dal X al IV secolo prima di Cristo, che si chiedevano perché Dio permette che l’uomo giusto soffra. E la semplice risposta è che Dio ha progetti non umani.
Ci sono tante altre esagerazioni che sono state proposte.
Il libro più bello e profondo sulla Shoah resta I SOMMERSI E I SALVATI di Primo Levi, che racconta la Shoah da testimone e da scienziato.