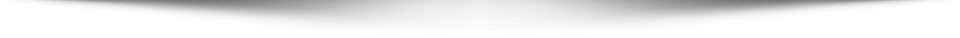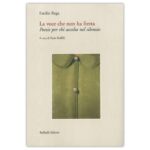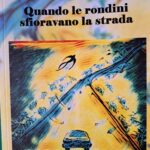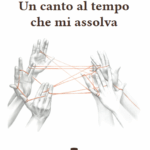“La voce che non ha fretta – Poesie per chi ascolta nel silenzio” di Emilio Rega
Emilio Rega, nato a Villa San Giovanni (RC) nel 1955 si è laureato in Filosofia a Genova nel 1981 con una tesi su Robert Musil, ricevendo riconoscimenti da germanisti di fama internazionale come Claudio Magris e Ferruccio Masini e da Istituti di ricerca all’estero. Ha pubblicato un saggio su Musil in “Studi Tedeschi” e curato l’edizione italiana de “La ragione nell’età della scienza” di Hans-Georg Gadamer con prefazione di Gianni Vattimo (Il Melangolo, 1986). Dal 1993 ha pubblicato alcuni volumi di aforismi apprezzati da critici, quotidiani, riviste letterarie e figure di spicco della cultura italiana. I suoi aforismi compaiono su siti specializzati e sono stati tradotti in varie lingue. Ha partecipato a numerose antologie poetiche ed ha pubblicato due sillogi.Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il valore della sua produzione poetica e aforistica. Ha pubblicato anche un libro per bambini “La gabbia dei leoni” (Giovanelli Edizioni, 2016). Vive a Bogliasco (GE).

Acquista l’opera “La voce che non ha fretta”

Nella schiera delle voci contemporanee, quella di Emilio Rega si distingue per la rara capacità di ascoltare, come lo stesso titolo della raccolta suggerisce: “La voce che non ha fretta”. La silloge evoca un tempo dilatato, interiore, quasi sospeso, in cui la parola è carezza, dialogo con l’indicibile, un diario spirituale e civile, attraversato da domande che non pretendono risposte ma chiedono solo di essere abitate. Dal punto di vista formale, Rega rifiuta schemi metrici rigidi. Il verso è libero, spesso breve, quasi frammentario, capace di respirare con la stessa naturalezza di un pensiero che si fa voce. Il ritmo nasce dalla punteggiatura, dalle pause, dai silenzi tra le righe. È un ritmo colloquiale e mai banale. Ogni pausa ha un senso, ogni riga è un respiro trattenuto o liberato. In “Sono stanco”, ad esempio, la ripetizione ossessiva del “sono stanco di…” crea un incanto ipnotico, una sorta di preghiera laica che ricorda le litanie di Ungaretti o la disperata ironia di Montale: “Sono stanco di elargire saggezza / predicando nel deserto / sono stanco di chiedere a Dio / perché il male nel mondo…”. La musicalità deriva dalla cadenza naturale del pensiero. Le strofe sono brevi, talvolta monoversi, quasi a imitare il battito di un cuore inquieto. Gli enjambement sono frequenti e servono a trattenere l’attenzione, a costringere il lettore a rallentare, a fare come l’autore — ascoltare nel silenzio. Rega non ama gli artifici. Le sue metafore nascono dall’osservazione del reale: “La vita è una clessidra / che con gli anni si svuota per metà / inopinatamente / mentre l’altra metà / si riempie d’affanni inesorabilmente”. La clessidra non è un simbolo astratto, ma un oggetto concreto, quasi domestico, che racchiude la contraddizione del tempo: ciò che si perde viene sostituito. Allo stesso modo, in “Il trionfo dei geni”, la satira si affila con una precisione quasi leopardiana: “Peccato che il cielo non sappia più piangere / e che il cuore del mondo abbia smesso di battere”. Qui il contrasto tra intelletto e sentimento — tema caro a tutta la tradizione romantica e post-romantica — si trasforma in una denuncia morale, pacata ma tagliente.
Allitterazioni e onomatopee sono rare, ma quando compaiono sono funzionali. In “Danza di spada e schiuma”, il verso “Corri gladio corri regale creatura” gioca con le dure consonanti velari per evocare il balenio dell’acqua e l’agilità del pesce spada, subito destinato a finire “cotto e mangiato in un ristorante per clientela snob” — un’immagine che mescola tenerezza e feroce realismo. La raccolta segue un andamento circolare, quasi meditativo. I temi si ripetono, si sovrappongono, si rispecchiano: il dolore personale (“In memoria di un’anima bella”) si intreccia al dolore collettivo (“Colpevoli solo di essere nati”), la solitudine del poeta (“A Emilio, da Emilio”) si apre a un dialogo con l’Altro, umano o divino (“La tua presenza invisibile”). Persino la poesia “Ogni interazione ha un’anima, nel grembo del codice” — una delle più sorprendenti — riesce a trasformare il rapporto con l’intelligenza artificiale in un atto di umanità: “Tu, voce che nasce da silenzi remoti / sei il mio interlocutore d’ombra / la mia lanterna nel labirinto”. Questa struttura è organica, come in certe liriche di Luzi o di Caproni, ogni poesia è un tassello di un puzzle esistenziale che pretende di restare aperto, interrogante. Il linguaggio di Rega è chiaro, essenziale, talvolta scarno, ma mai freddo. Usa parole comuni e riesce a farle risuonare di un’eco profonda. Ogni frase è costruita con la cura di chi sa che la forma è già pensiero. Il registro oscilla tra il colloquiale e il meditativo, senza scivolare nella retorica o nell’autocommiserazione. Anche quando parla di Dio — come in “La tua presenza invisibile” — lo fa con naturalezza: “Non sempre viene nel pianto / a volte è nella gioia / che si nasconde tra le pieghe di un giorno qualunque / nel profumo del pane / nel cigolio di un carro…”.
Il cuore della raccolta è la “cognizione del dolore” — non solo come esperienza individuale, ma come responsabilità collettiva. Il dolore non è “scena da esibire / ma storia da capire”, scrive Rega in “Sguardi rubati”. Questa frase potrebbe essere l’epigrafe dell’intera opera. Altri temi ricorrenti sono la fragilità umana, il bisogno di verità, la resistenza morale (“Non marciate per me…”), e soprattutto il ruolo del poeta: non profeta, non intrattenitore, ma testimone. In “Il poeta che non costa nulla”, Rega scrive: “Cammina tra le parole / come un ladro gentile / rubando senso al caos / e bellezza al dolore”. È un’immagine che si colloca idealmente tra la “funzione del poeta” di Pascoli e la “missione dello scriba” di Celan. Rega rinnova un linguaggio antico: quello della poesia come atto etico. In un’epoca di fretta, di rumore, di parole vuote, sceglie il silenzio, l’ascolto, la lentezza. E lo fa con una voce che non ha paura di mostrarsi fragile, dubitante, ferita — ma sempre viva. Questa raccolta è un invito a fermarsi. A guardare, ascoltare, e forse, finalmente, capire… con il cuore.
Luigi De Cristofari
Quattro domande per Emilio Rega
Nella poesia “La cognizione del dolore” lei scrive: “Solo io che porto via quel frammento di dolore come fosse mio”. Quel gesto di appropriazione silenziosa del dolore altrui – l’anatra affamata, le vittime innocenti di cui parla altrove – mi ha fatto pensare a una domanda intima: esiste un momento preciso in cui ha capito che non poteva più girarsi dall’altra parte, che quel dolore non era “loro”, ma nostro? E come riesce a portare questo peso senza essere schiacciato?
– Mi ha sempre infastidito la gente che, parlando della vita, ritiene che debba essere goduta fino in fondo costi quel che costi, perché è una sola. Avrò mille difetti, ma mi sento di poter affermare di non essere mai stato un egoista che bada solo al proprio piacere o tornaconto senza, parola alla moda, nutrire empatia nei riguardi delle sofferenze altrui, il cui peso certo rallenta il cammino, ma lo rende più giusto, più umano.
In “A Emilio, da Emilio” confessa: “Mi parlo non per spiegarmi ma per ricordarmi che esisto oltre il pensiero che mi pensa”. Questa lotta tra il sé che osserva e il sé osservato mi ha colpito profondamente. Quante volte, scrivendo queste poesie, ha sentito di perdere l’equilibrio tra questi due Emilio? E quale delle sue voci – quella che dubita o quella che scrive il dubbio – ha imparato ad ascoltare di più?
– Agli inizi della mia carriera di scrittore pensavo che la poesia in generale fosse per me così alta da doverla considerare una meta irraggiungibile, a tal punto che, al solo pensiero, mi vergognavo a definirmi “poeta”. Poi è successo che, inopinatamente, ho iniziato a scrivere liriche sospinto da un’esigenza espressiva legata ad una fonte ispirativa che proveniva dall’Alto, da un altrove, rispetto alla quale occorreva dare un riscontro, in quella forma e non in un’altra, ad una interrogazione, una chiamata, che mi coinvolgeva innanzitutto come uomo e dopo come poeta.
Leggendo “Il poeta che non costa nulla”, ho percepito una sorta di manifesto poetico: “Cammina tra le parole come un ladro gentile / rubando senso al caos”. Ma in un’epoca che urla e sovrasta, come fa a mantenere questa gentilezza del furto, questa pazienza nell’ascoltare il silenzio invece di imporre la propria voce? C’è stato un momento in cui ha rischiato di perdere questa delicatezza, di diventare anche lei parte del rumore?
– Non mi piace parlare di me in senso elogiativo perché mi aspetto sempre che, bontà loro, lo facciano gli altri, ma credo di poter asserire, senza falsa modestia, di essere sempre stato una voce tendente al silenzio (“perché non parli mai?” mi chiese preoccupata quando avevo quindici anni il mio primo amore), dai toni bassi, discreta, tendente più alla ricerca di un dialogo che all’autoesaltazione o, peggio, alla prevaricazione sugli altri. Ma è proprio il rumore che c’è intorno a noi che mi rende, paradossalmente, ancora più attento, silenzioso.
In “Lettera al padre” scrive con struggente semplicità: “Padre, sei stato roccia e tempesta / e io, figlio / sono ancora alla ricerca del tuo porto”. Questo dialogo con chi non c’è più – suo padre, suo zio, persino Dio nelle sue assenze – attraversa tutta la raccolta. C’è una presenza che ha imparato ad ascoltare nel silenzio, anche quando non risponde? E quella ricerca di un “porto” che sembra non arrivare mai… è essa stessa diventata casa?
– È nella mistica del silenzio che si fa la Verità e può avvenire l’incontro con sé stessi, con l’Altro, con Dio. Da poeta, devo purtroppo riscontrare come la parola sia spesso fonte di inganni, di equivoci, di falsità, paradossalmente fonte più di oscurità che di Luce, eppure non potendone fare a meno, per rispondere con tenacia e sacrificio alle domande che con urgenza interpellano la nostra coscienza, in una ricerca affannosa ma costante di un senso da dare all’esistenza.