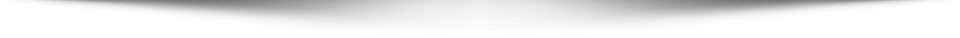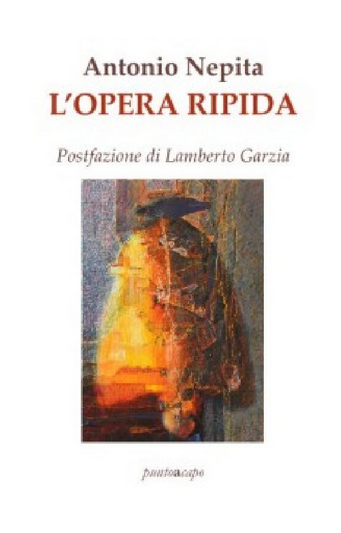
1° classificato per la poesia edita – Premio Nabokov 2024
Antonio Nepita, L’opera ripida – Una poesia che sale, anche quando scende
Leggere L’opera ripida di Antonio Nepita è come camminare su un sentiero di pietra viva: ogni passo richiede attenzione, ogni respiro si fa più denso, eppure non si vorrebbe tornare indietro. Non tanto per la fatica — che pure c’è, e si sente — quanto per la luce che, a tratti, filtra tra le fronde, tra le crepe dei muri abbandonati, tra le parole stesse.
Nepita, pittore oltre che poeta (e forse poeta proprio perché pittore), costruisce un paesaggio interiore che è al tempo stesso geografia reale: quella dell’entroterra ligure, aspro, verticale, segnato da terrazze strappate alla montagna e vite consumate in silenzio. Il libro è diviso in sezioni luminose — L’alta luce, La bella luce, Luce radente, Luce flebile — quasi a suggerire che la poesia non è un unico sguardo, ma una serie di inclinazioni diverse dello stesso raggio solare su una pietra antica.
Non si tratta di versi decorativi. Nepita non addolcisce il mondo: lo scava. Ne tira fuori il sudore, l’urina degli ubriachi, la tosse degli asini, la “pisside vuota d’ostie”, i blister dei medicinali, le “mine inesplose” dei corridoi domestici. Eppure, in questa materia grezza, brucia una tenerezza ostinata. C’è un amore per ciò che resiste — i ruderi, i semi chiusi in una mano, le vigne “bastarde per tradizione”, il “flauto del bambino” portato in un rifugio senza tempo.
Una delle cose che più colpiscono è la voce: mai retorica, mai compiaciuta. Nepita parla con la terra, con i fantasmi, con gli alberi, con un’amante, con se stesso — ma sempre da pari a pari, senza gerarchie. Anche quando scrive d’amore — e lo fa con una sensualità rara, fatta di “busto rosso”, “ombelico sacro”, “mano che non chiede il conto” — non indulge al lirismo facile. Il corpo è materia, sì, ma anche mistero; la bellezza è reale, ma fragile come un petalo nel catrame.
La postfazione di Lamberto Garzia, che apre con una citazione petrarchesca sull’ascesa al Monte Ventoso, coglie bene il cuore del libro: L’opera ripida è un’ascesa. Non verso un paradiso astratto, ma verso una forma di verità terrena, fatta di fatica, memoria e attenzione. E come nel racconto del Petrarca, anche qui “la natura non cede alla volontà umana”: non basta voler salire per arrivare in cima. A volte bisogna accettare di scendere, di perdersi, di restare “lunghi tra ombra e sole”, come quegli uomini e quelle donne della valle a cui Nepita dedica il libro — “nati e morti vicino ai muri con in pugno l’oro del niente”.
Eppure, in quel “niente” c’è tutto. C’è la dignità di chi ha “diviso la fatica con i muli”, di chi ha “guardato il mare da lontano” senza poterci andare. E c’è, soprattutto, la poesia come gesto di resistenza: “Ho soffiato sul seme prima di lasciarlo nella macchia morta. / Un gesto senza testimoni…”.
L’opera ripida non è un libro facile, ma è un libro necessario. Per chi crede che la poesia debba ancora parlare del mondo — con le mani sporche, gli occhi aperti e il cuore non troppo ben pettinato.
Silvia