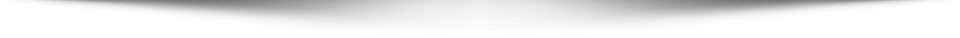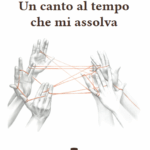CORRISPONDENZE di Maria Benedetta Cerro non è solo una raccolta di testi scritti da autori contemporanei. Ha una singolarità. Non si limita, infatti, a raccogliere opere significative o riflessioni intorno a esse, ma punta a un autentico dialogo poetico, concepito nella duplice modalità dello specchio e dell’incastro (e sulla polisemia letteraria di questi due termini si potrebbe dire qualcosa, visto che il primo termine evoca una poesia che è riflesso del testo di partenza e il secondo, l’incastro, richiama versi che si intrecciano ad altri in modo non lineare). La Cerro, così precisa nella Premessa, cerca di «stabilire un dialogo, se non di comprensione profonda, almeno di richiamo a quell’a-priori corporeo, comune a ciascun essere umano» (p. 5). Lo sforzo è, dunque, comprendere un poeta, risalendo a quel vissuto emotivo, sensibile che innerva la sua esperienza, senza cercare una forma necessariamente affine al proprio sentire, ma disponendosi all’ascolto dell’alterità, di ciò che esula dalle proprie categorie. Ho trovato interessante questo riferimento alla corporeità, all’interrogazione testuale, intesa come corpo-a-corpo, non lettura pacifica. Certo, l’operazione non è facile, perché la poesia conserva sempre una nota personalissima quando è autentica. Le sue idiosincrasie nascono da quel groviglio, Gadda direbbe ‘gliommero’, di energie, sentimenti, ferite che connota l’esistenza di ciascuno e che è problematico portare alla luce.
Lo sforzo è, dunque, comprendere un poeta,
risalendo a quel vissuto emotivo,
sensibile che innerva la sua esperienza
Il titolo dell’opera, Corrispondenze, mi sembra richiami il Foscolo dei Sepolcri dove la ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ è la comunicazione che i vivi intrecciano con chi non c’è più. La poesia si nutre di altra poesia, sopravvive attraverso la memoria di altri poeti. Ma questo legame intertestuale potrebbe esser letto anche in un altro modo, come interrogativo su chi sia il poeta nel mondo moderno e perché sia ‘morto’ o assuma i contorni di una presenza spettrale: perché è lontano dalle convenzioni del contesto storico in cui vive? È forse incompreso in un mondo moderno assoggettato alla logica capitalistica del calcolo? Insomma, credo che questo libro ponga anche una domanda su dove sia la poesia nella società attuale e se vi sia uno spazio reale per essa.
Come dicevo, la Cerro rielabora poesie di altri autori, sia componendo un secondo testo poetico che risponde al primo, sia creando intrecci ibridi, con strofe dell’autore, diciamo così, originario, e strofe proprie. Di tali riscritture preferisco, a dire il vero, proprio gli incastri dove le due voci poetiche in dialogo sono distinte tipograficamente tramite il corsivo (per il poeta-sorgente) e il font normale (per la risposta). È visibile anche una particolare disposizione spaziale dei versi sulla pagina. Così, nel dialogo con la poetessa Maria Pia Crisafulli, la poesia è un’esperienza dirompente, quasi un’entità autonoma che, come un personaggio pirandelliano, va alla ricerca dello scrittore, ‘sparpagliandolo’ sul banco:
Strappavo le pagine
e solo dopo
scrivevo.
Io cercavo margini / angoli / ritagli
– non c’era pagina degna –
La poesia mi trovava
sparpagliava sul banco
senza mai ricomporre
e così mi consegna
[…]
Vorrei scriverti
le labbra
percorrerle e affondarle
come la penna
sopra il foglio
È questa bocca come un calamaio
– nero inchiostro invece di parole –
Se attingi l’anima / la uccidi
(pp. 28-29)
L’identità non è ricomposta armoniosamente, ma messa alla prova da versi che hanno un’origine corporea, non-verbale, quindi, difficile da condividere, quell’apriori di cui la Cerro parla nella Premessa. Lo strappo evidenzia come la pagina sia una prigione: è troppo limitata per contenere un’energia che, gradualmente, diventa desiderio di scrivere, non sulla carta, ma sulle labbra dell’altro. La poesia è, cioè, prima di tutto, una relazione ‘eccessiva’ tesa a carpire i segreti dell’anima altrui e, tuttavia, facendoli emergere allo scoperto, rischia di ucciderli.
La poesia è una relazione ‘eccessiva’
tesa a carpire i segreti dell’anima altrui
In molti casi, le rielaborazioni offrono immagini malinconiche di dolore e assenza, come avviene in Rosa carsica di Antonio Vanni. Qui il ricordo della madre defunta è colto nei dettagli quotidiani (la borsa della spesa, il filo di caffè ecc.), ma anche nella rosa che cade «dal cuore spaccato di lei» (p. 30), orma sulla lapide. Nel testo a specchio di risposta, il dolore condiviso è suggerito dall’incrociarsi simbolico delle ombre:
La mia ombra verticale
la sua orizzontale.
Insieme siamo una croce
(p. 31)
Altri componimenti si soffermano sui particolari sognanti della natura, come i fogli distesi al tramonto, le sospensioni di righe di Elisa Nanini per la quale il «perdono autunnale / è un profumo ruvido/ dal tuffo di libellula» (p. 42). Nella metaforicità che fa della natura una pagina scritta, il biancore dello spazio tra i versi si confonde con la luminosità bagnata di pioggia recente:
Dopo un punto fermo,
i colori spaesati delle storie
si specchiano nello spazio bianco:
ti affacci al balcone, la luce
fa emergere per contrasto
la pioggia che pesa sull’erba,
pianti sconosciuti, gioia di vivere.
Eleganza amara, in bilico
tra la danza classica e il graffio
del rock […]
(ivi, p. 42)
«senza mai strappare i gigli di mare
alle montagne»
Nel testo a incastro di Nanini e Cerro, Un guanto tra la neve, la metafora della scrittura si sposta dal mondo naturale al corpo: ci sono, infatti, espressioni scritte sul viso, «come le dediche scoperte a distanza di anni» (p. 44), e il volto è segnato dal pianto carsico (di nuovo, questa parola che suggerisce profondità) e da sofferenze silenziose. È universale questo linguaggio corporeo plasmato dalle rughe dell’esistenza («Tu vedi / tu leggi in quel libro / di tutte le lingue le scritture», p. 44).
Ogni cosa sembra perdere senso fino a quando, in un paesaggio esistenziale apocalittico, compare un oggetto enigmatico, lo sprazzo di un guanto posto tra due contrari: un universo di terra (la neve), da una parte, un universo equoreo, fluido, dall’altra («la linea sonora degli scogli»). L’oggetto, senza mano, evoca l’assenza; anche la stoffa di cui è costituito, non riesce a raccontarsi fino in fondo, come avesse smarrito il linguaggio che serve a ricordare la vita della persona alla quale quel guanto appartenne. Per lo stesso motivo il tessuto non parla, ha smarrito il suo peso emotivo, tipico delle cose che hanno un valore personale. Tuttavia, si percepisce ancora un residuo, il suo scivolare «nei solchi / di un paesaggio ruvido di sale» (p. 44).
il guanto senza mano e il filo d’erba
L’oggetto, anche se evanescente e consumato, lascia una traccia percettiva, tattile, con una modalità che mi ha ricordato certe solarità marine di Caproni o Montale dove il sole non illumina, ma scarnifica e rinsecchisce. Nella prospettiva della Cerro lo spazio sembra avere senso solo se popolato di segni umani. Questi ultimi, però, tendono a rarefarsi, diventano parvenze, figure che si crede soltanto di vedere, oggetti persi e abbandonati, privi della consistenza originaria che dava loro senso. Sono tracce di umanità che non vengono preservate dallo sguardo, piuttosto vi precipitano. La realtà è, quindi, una corrente fluida da cui affiorano detriti misteriosi: il guanto senza mano, «un filo d’erba che era sussurro / ora segna-pagine / e racconto» (p. 45). In tale umanizzazione della natura il filo suggerisce il rumore dell’erba contro il vento o, magari, i sussurri di un innamorato, con un movimento che passa dall’apertura del mondo naturale all’artificio delle pagine scritte quando quel filo sarà, ormai, divenuto secco all’interno di un libro. Mi piace pensare, allora, alla penna poetica come alla capacità di sfogliare la realtà concreta, ritrovando ciò che è stato abbandonato, i segni di una presenza emotivo-esistenziale che si può cogliere solo accettando il paradosso di una visione inusuale, «senza mai strappare i gigli di mare / alle montagne» (p. 45). La poesia è, in effetti, questo coraggio che fa crescere gigli marini nel posto sbagliato, è strappo e carezza insieme, poiché lacera la convenzionalità del vedere e, nello stesso tempo, valorizza nuovi significati.
Nel dialogo con la poetessa Chiara Mutti e il suo componimento Io vivo. Ma se fossi sogno?, il dettaglio non abituale (la positività della notte e il giorno che diventa, invece, una condanna) arriva a un rovesciamento totale delle cose: «i colori brillerebbero di una tale infamia» (p. 54) che la notte sarebbe l’unico porto sicuro. Così le stelle, invece che illuminare il cielo, lo rendono nero, imprigionandolo. Il testo a specchio della Cerro accoglie l’idea originaria dell’esistenza come apparenza e sogno, ponendo l’accento, però, sull’attraversamento tra vita e non-vita, sull’incertezza del confine. Lei stessa non appartiene più alla chiarità del giorno, ma al suo retro («Io nel retro / e avanti la sciagura del giorno truce e della falsa luce», p. 55), perché la luce stessa maschera qualcosa. Anche la poesia a incastro evidenzia la negatività del giorno che «ha piantato una lama nel cielo e sul sangue erige il suo vessillo» (p. 56). Il sole storna i raggi dalla sua stessa opera in una una sorta di ribellione che scardina il creato e che ricorda alcuni paesaggi scavati del calabrese Lorenzo Calogero, poeta che ha ispirato il mio libro Radici come parole (Aletti, 2023) nel «paesaggio tagliato con furia» (Polvere sullo specchio, p. 37), nel mondo lacerato che mostra il suo nucleo interno, e ogni pianta – edera, felci, mirtilli, pini loricati del Pollino – sembra fossilizzarsi. Il titolo della mia poesia, in realtà, richiama la polvere visionaria di un altro poeta, Dino Campana («Passano nella veglia opime di messi d’amore, leggere spole tessenti fantasie multicolori, errano, polvere luminosa che posa nell’enigma degli specchi» in La Notte, in I Canti Orfici, Milano, Rizzoli, 1989, p. 102) che scrive con «il sangue alle dita» (La giornata di un nevrastenico, ivi, pp. 173-174), passeggiando sotto i portici bolognesi dai quali piovono gocce di luce sanguigna. Ho menzionato questi riferimenti perché mi sembra che colgano una tonalità presente in Corrispondenze, una luminosità paradossale, privata del suo segno distintivo.
«misi una sedia al centro della mia
stanza, in attesa dell’interrogatore. diceva di
cercare un nome, un nome da dare a tutto
questo»
Su questa linea spettrale si muove, per esempio, la scrittura di Eda Özbakay che, secondo la Cerro, è quasi orfica, come volesse inviare messaggi enigmatici all’umanità, «con sconfinamenti nell’assurdo» (p. 10) in bilico tra sogno e realtà; le sue sono microfinzioni capaci di valorizzare la soglia, letta anche, a livello linguistico, come incerta linea di confine tra poesia e prosa:
un nome
ogni sera, alle sei, si sentiva la salva di
saluto. quel cannone continuava a sparare,
anche se non era rimasto quasi nessuno da
salutare.
le case bruciavano sempre durante la notte,
mai di giorno. noi vestaglie bianche, tarme
intorno alle fiamme, ci radunavamo sulla
sabbia in salita, in silenzio.
ero fortunata. abitavo in una curva stretta,
troppo stretta per le camionette che nella
sterzata perdevano parte del loro carico dai
cassoni. un cocomero, acqua, delle cipolle.
quando non era rimasto più nessuno nel
villaggio, misi una sedia al centro della mia
stanza, in attesa dell’interrogatore. diceva di
cercare un nome, un nome da dare a tutto
questo
(p. 58)
Il dramma della guerra (?) entra obliquamente sulla pagina, lascia percezioni intermittenti, oggetti isolati: la salva del cannone in un mondo in cui non c’è più nessuno da salutare, le case arse di notte, gli uomini ridotti a tarme in vestaglie bianche, senza corporeità. Nell’ultima strofa, in un’atmosfera da teatro dell’assurdo, compare una sedia al centro della stanza dove la poetessa attende un interrogatore, qualcuno che cerchi un nome da dare a ciò che sta accadendo. Non si comprende bene se tale inquisitore abbia una funzione positiva o negativa, ma i versi dicono qualcosa sul farsi della poesia che è sostanza linguistica, tentativo di nominare le cose in una maniera significativa, dando valore anche al silenzio. Mi viene in mente il commento di Marta Rota Núñez al libro di poesia per bambini, Il segreto delle cose della cilena Maria José Ferrada, con illustrazioni di Gaia Stella, edito da Topipittori (2017):
«Ritiene che la poesia viva sempre in uno spazio sospeso tra il detto e il non detto, e che proprio per questo abbia bisogno di un lettore attivo, disposto a completare con la sua esperienza lo spazio che c’è tra il testo e il silenzio che lascia sul foglio»
(https://www.topipittori.it/it/topipittori/il-mormorio-degli-oggetti-intorno-noi)
Ecco questo intrecciarsi di detto e non-detto è evidente nella poesia a specchio con cui la Cerro risponde a Eda. Sembra, prima, voler mitigare la solitudine spettrale del primo testo, facendosi compagna dell’io lirico, ma poi arriva la precisazione: lo sdoppiamento, in realtà, non assicura la presenza dell’altro («Di certo eravamo in due. / Ma non so chi fosse l’ombra che mi accompagnava / – quindi ero sola – Cercavamo gli Altri. / Io badavo dove mettere i piedi», p. 59). L’altro rimane uno sconosciuto in un paesaggio di ruderi, fratte, spine, case scomparse. La visione è sfocata, non rassicurante e, allora, perfino la memoria inganna e le strade ricordate non sono mai esistite. Resta costante e intensa la ricerca di un contatto interpersonale, anche se gli esseri umani sono spaventapasseri scarnificati, «covoni di paglia in cammino / un ciuffo al posto della testa» (ivi, p. 59). La poetessa chiede, quindi, all’ombra che l’accompagna, un Virgilio un po’ gotico, chi siano tali esseri di paglia:
«Furono – rispose – Sono.
Anche noi
fummo».
Nella conclusione la terra è come abrasa da un conflitto che non è tanto un dramma storico quanto una perdita d’identità, di certezze, di umano. Le persone sono sopravvissuti in attesa di qualcosa che non arriva mai. Tra finzione e reale, fra visibile e invisibile. Nel dialogo con Ada, in effetti, il tema della soglia diventa esplicito, evidenziato, anche tipograficamente, dalle inarcature che spezzano le parole a fine verso:
la frontiera – A
sempre diritto! mi risposero
mentre oltrepassavo la fron-
tiera, salutandomi con un bat-
tito di ciglia di pelle nera e
penzolante.
Può andare. – Vada –
(e-sitavo)
Per andare dove non vuole
non ci sono istruzioni.
Chiuda gli occhi. Inventi la terra
dove mette i piedi.
Il viaggio di questo misterioso io migrante (la poetessa?) assume toni metafisici, esistenziali. Non c’è bisogno di autorità doganali che impediscano il transito, perché non ci sono istruzioni e anche la meta è definita in negativo, è un andare dove non si vuole. Non c’è un terreno già tracciato, esso va creato dal nulla. Un varco esiste, tuttavia attraversarlo è difficile, come se un muro magnetico invisibile impedisca il passo e gli uomini siano prigionieri di un nuovo deserto dei Tartari:
la frontiera – C
per oltrepassare il varco oc-
corre ammorbidire la facciata
della cabina di controllo con
il proprio alito. in molti ri-
mangono incollati con la lin-
gua al vetro, le fitte in bocca.
L’io va controllato, scrutato, poiché non rientra nei canoni comuni:
Documenti, prego.
Senza alzare gli occhi.
Vada nella stanza accanto per la visita.
Mi tocca le labbra, mi scruta cima a fondo.
Un caso da studiare – dice la soldatessa –
Si tenga pronta.
la frontiera – D
per non dare nell’occhio,
qualcuno cercò di tenere fermi
i propri pensieri.
questi non si muovono più. o li
togliete o tornate indietro
In fila per il visto.
Lei – dico a lei – cosa porta con sé?
Come dire ‘così tanto di tutto?
e tanto peso?’
Mette in bocca tranquillissimi nodi.
Deve scioglierli tutti prima di parlare.
Nelle strofe precedenti, accanto all’io lirico, emerge una collettività di persone. Tutte devono essere ispezionate, ma è inquietante il vero obiettivo dell’ispezione militare: togliere i pensieri in movimento, fare in modo che non circolino. Lo scopo delle autorità è mettere a tacere il pensiero che non ha sciolto i suoi nodi, quello problematico, critico, in grado di scardinare i partiti presi.
Mettere a tacere la poesia?
Stranamente, in questo incastro poetico, non compare la frontiera B … mi sono chiesta il motivo, senza riuscire a trovarlo. Quindi, mi sono detta: perché non trasformare questa recensione in una riscrittura creativa e aggiungere la strofa ‘mancante’ in modo che le voci poetiche in comunicazione siano tre? In fondo, il libro dimostra proprio questo: che ogni poesia vive di riletture e riscritture e che non bisogna avere paura di confrontarsi con linguaggi diversi dal proprio, osando contaminazioni. Il brulicare delle immagini diventa, allora, una nuova personale sintesi, una parola multipla in cui non si sa dove finisce il sentire di un poeta e inizia quello di un altro:
la frontiera B
Inventerò la terra sotto i piedi,
sì, lo farò togliendo il guanto
e impastando le mie mani nei gi-
gli di mare della front-
iera tra spiag-
gia e fresca neve.
Li poserò sui pensieri,
sulle labbra per da-
re nell’occhio.
Durante l’ispezione.
Per così esserci.
Riporto qui di seguito, per intero, la poesia Un guanto tra la neve di Elisa Naninida cui è tratta l’immagine dei gigli di mare (in Corrispondenze ci sono, naturalmente, altri autori meritevoli, ma il presente scritto presenta, per forza di cose, solo una selezione, personale e, quindi, anche opinabile, degli aspetti che mi hanno colpito di più):
Un guanto tra la neve
[…]
Tu vedi / tu leggi in quel libro
di tutte le lingue le scritture.
con il piccolo sprazzo
di un guanto tra la neve e
la linea sonora degli scogli:
la mano assente che ti saluta
una stoffa che non può raccontarsi
fino in fondo ma che senti
scivolare nei solchi
di un paesaggio ruvido di sale.
Nessuno spazio è immacolato
un oggetto / un suono
una figura che credi di vedere
ed è lontana
un panno perso e abbandonato
Tutto appare e precipita
nell’abisso salato dello sguardo.
Un guanto solo come indizio
di cinque dita al freddo,
un lungo filo d’erba
dentro le pagine.
Un guanto
che ha perso la mano
un filo d’erba che era sussurro
ora segna-pagine / e racconto
Si sfoglia, parla commosso alla terra
l’abbandono ritrovato e donato
dal marciapiede bianco
senza mai calpestare il paradosso
e la carezza,
senza mai strappare i gigli di mare
alle montagne.
All’occhio che passa e non vede
dice il dono
dell’abbandono e del ritrovamento
il paradosso dello strappo e la carezza
la cura / che è taglio e sutura
come lasciare in pace la bellezza
– accarezzare con gli occhi
fino a farsi ciechi –
Anna Guzzi

Immagini da https://pixabay.com/it/, liberamente rielaborate